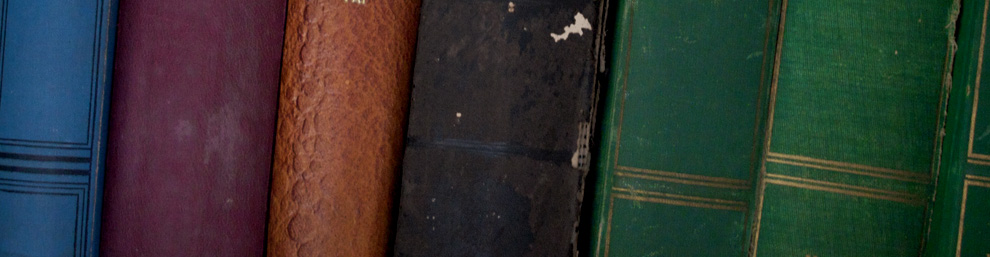L’invidia della vita dell’Altro che spesso opprime i soggetti nevrotici — l’invidia come l’amore non ha come oggetto una qualità dell’Altro, ma è pura “invidia della vita”‘ dell’Altro —, viene sostituita dalla contemplazione ammirata di quella vita. Per questo, giustamente, Freud notava come molti pazienti oscillano spesso dai sentimenti di amore a quelli di odio e viceversa. L’invidia e l’ammirazione sono infatti due sentimenti molto prossimi. Ma mentre nell’invidia l’invidioso vive come un dolore l’esistenza libera e vitale dell’Altro, nell’ammirazione questa stessa esistenza procura soddisfazione e accresce il desiderio.
M. Recalcati, Non è più come prima, 121